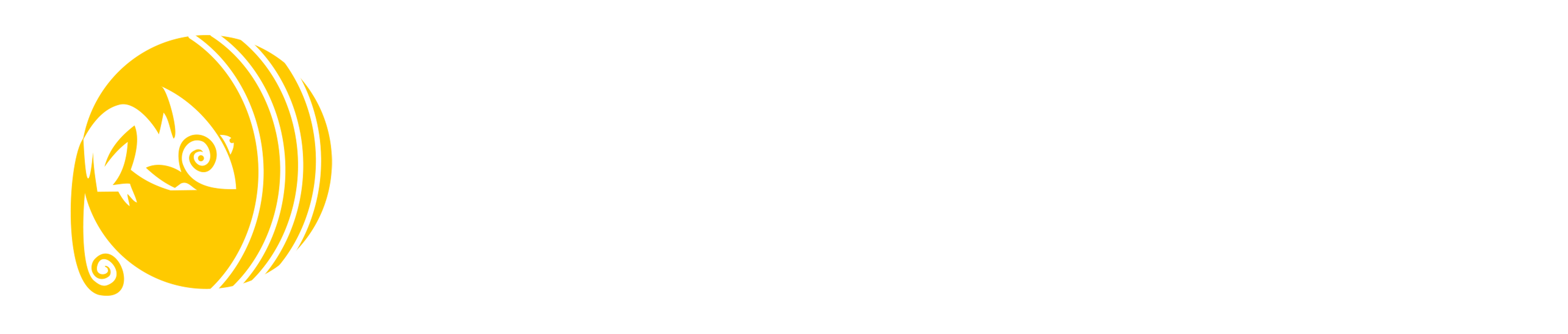Abbiamo già parlato dei siti Patrimonio Unesco che conosciamo in Italia e nel mondo, ma questa volta vogliamo concentrarci sul sito seriale “I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)”, i sette luoghi con le più importanti testimonianze longobarde esistenti sul territorio italiano.
I luoghi del potere dei Longobardi in Italia
Perché? Il sito fu inserito tra i Patrimoni dell’umanità da preservare nel 2011, esattamente 10 anni fa. La data del decennale è il 25 giugno e sono previste diverse iniziative in cui protagonisti saranno tutte le più grandi testimonianze monumentali del nostro Paese dislocate in 7 punti della penisola, dove si estendevano i domini dei più importanti Ducati longobardi.

Il più vicino a noi, che fu uno snodo fondamentale della Via Sacra Langobardorum una delle più antiche rotte di pellegrinaggio, è MONTE SANT’ANGELO dove chi era diretto in Terra Santa sostava nella Grotta di San Michele.

L’importanza del luogo crebbe nel tempo raggiungendo l’apice in epoca longobarda quando divenne santuario in onore di Michele a cui vennero attribuite le virtù di Wodan (Odino), dio germanico della guerra. Ad accogliere visitatori e pellegrini è la candida facciata in cui è incastonato lo splendido portale del 1300 con la lunetta scolpita con Maria, fra i santi Pietro e Paolo. Su tutto si erge la Torre fatta costruire nel 1274 da Carlo I d’Angiò come ringraziamento per la conquista dell’Italia meridionale.
Una volta entrati, una lunga scalinata conduce alla chiesa a una navata sormontata da volte a crociera che introduce alla Grotta in cui Michele, il più luminoso e potente dei tre arcangeli, apparve nel V secolo. Al centro c’è la scultura dell’arcangelo in candido marmo di Canova realizzata da Andrea Ferrucci da Fiesole, allievo del Sansovino.

Al di sotto della Grotta, nella parte più antica del santuario, sono visitabili gli ambienti longobardi con iscrizioni in caratteri runici, usati dai Longobardi prima di adottare l’alfabeto latino. Nell’attiguo Museo lapideo sono conservati reperti rilasenti a epoche dal VII al XV secolo. Molto interessante anche il Museo devozionale che custodisce reliquiari, paramenti sacri ed ex voto.

Ma non è finita qui. La cittadina garganica vanta ben due siti Unesco: oltre al Santuario ci sono infatti le faggete vetuste della Foresta Umbra, cuore del Parco nazionale del Gargano. Da non perdere, insieme alla passeggiata all’ombra di alberi che raggiungono anche i 300 anni di vita e gli oltre 40 metri di altezza, una visita alla chiesa di San Pietro con il Battistero di San Giovanni in Tumba, chiamato anche Tomba di Rotari, costruito agli inizi del XII secolo come battistero.
Al suo fianco la duecentesca chiesa di Santa Maria Maggiore è un vero gioiello del Romanico pugliese. Sul punto più alto del paese si staglia il castello, mentre nel quartiere Junno protagoniste sono le casette bianche a schiera addossate le une alle altre.

Risalendo lo Stivale il secondo luogo longobardo è BENEVENTO, città in cui sorgeva il Sacrum Palatium, la reggia dei duchi e la sede della corte della Longobardia Minor, l’estrema propaggine del dominio longobardo in Italia.

Una delle più importanti testimonianze del periodo è la chiesa di Santa Sofia fondata dal duca Arechi II nel 760 come cappella palatina e considerata una delle costruzioni più originali dell’età tardo-medievale per la complessa pianta esagonale e il raro intreccio di volte. Accanto si trova il Museo del Sannio, che occupa il chiostro e l’antico monastero benedettino. Qui sono esposti reperti archeologici delle antiche città sannitiche ma anche corredi funebri, spade, monete e gioielli di epoca longobarda.
Da non perdere il chiostro con 47 colonne di provenienza e materiali diversi che sorreggono bellissimi capitelli scolpiti. A pochi passi si può visitare l’Hortus Conclusus, l’istallazione di Mimmo Palladino realizzata nel 1992 in uno degli orti del Convento di San Domenico. Su un precedente palazzo fortificato longobardo fu costruita la Rocca dei Rettori conosciuta anche come Castello di Benevento che oggi ospita la sezione storica del Museo.

Su corso Garibaldi si affaccia il cinquecentesco palazzo Paolo V in cui ha sede Janua Museo delle streghe o janare che secondo la leggenda si radunavano sotto un noce lungo il fiume Sabato. Una storia che si lega anche al Liquore Strega, prodotto in città dal 1860 con una ricetta segreta a base di 76 erbe.


Simbolo della Benevento romana è l’Arco di Traiano perfettamente integro e ricco di rilievi scultorei. I Longobardi lo inglobarono nella cinta muraria e lo ribattezzarono Porta Aurea. Nei pressi si trova il complesso di Sant’Ilario: la chiesa fu costruita nel VII secolo, epoca in cui i Longobardi furono convertiti al cattolicesimo dal vescovo Barbato, autore del taglio del famoso Noce delle streghe.

 Una delle nostre ultime “scoperte” longobarde è stata SPOLETO, splendida città umbra dal passato romano, medioevale, rinascimentale e anche e soprattutto longobardo. Preziose testimonianze della cultura longobarda sono conservate nel Museo nazionale del Ducato, ospitato nelle sale della Rocca Albornoz sulla sommità del colle San’Elia. Da qui si domina la città da una parte e Monteluco dall’altra a cui è collegata tramite il mastodontico Ponte delle Torri.
Una delle nostre ultime “scoperte” longobarde è stata SPOLETO, splendida città umbra dal passato romano, medioevale, rinascimentale e anche e soprattutto longobardo. Preziose testimonianze della cultura longobarda sono conservate nel Museo nazionale del Ducato, ospitato nelle sale della Rocca Albornoz sulla sommità del colle San’Elia. Da qui si domina la città da una parte e Monteluco dall’altra a cui è collegata tramite il mastodontico Ponte delle Torri.


Mentre la passeggiata in centro permette di ammirare il teatro romano all’interno del Complesso monumentale di Sant’Agata, l’Arco di Druso e il magnifico Duomo con gli affreschi di Lippi e Pinturicchio.


In terra umbra c’è anche il Tempietto Longobardo di CAMPELLO SUL CLITUNNO, riproduzione di un edificio sacro romano collocato su un podio che si erge nel Parco delle Fonti costituito da un laghetto, un’area verde di pioppi e salici e il Clitunno che sgorga da fenditure nella roccia.


Spostandosi a nord si trova il più importante centro longobardo in Italia: CIVIDALE DEL FRIULI, sede del primo ducato (568 d.C.), destinato a trasformarsi in una capitale politica e religiosa dominante. Qui il gioiello è il Tempietto Longobardo nel monastero di Santa Maria Valle, nato come cappella palatina della corte regia sulle sponde del Natisone unite dallo scenografico Ponte del Diavolo.
Per completare questo grand tour alla scoperta della storia dei Longobardi in Italia ci mancano due dei 7 siti, entrambi sul suolo lombardo: Brescia e Castelserpio in provincia di Varese, antico crocevia tra i valichi alpini e Milano, scoperto intorno alla metà del ‘900. La curiosità? Castelserpio-Torba fu acquistato negli anni ’70 da Giulia Maria Crespi che lo donò al FAI facendone il prototipo del patrimonio storico e culturale da salvaguardare.