Sin da piccola, quando alle scuole elementari ce li fecero riconoscere nei simboli presenti nello stemma cittadino, sono stata ammaliata dai “laghi non laghi” intorno a Conversano. In realtà quelli rappresentati dai 5 dadi intorno alla torre erano i 5 casali o villaggi che sorgevano nei dintorni del paese.

Ma ben 4 di loro, Sassano, Agnano, Iavorra e Castiglione sorgevano sul bordo di laghetti carsici che ancora oggi raccolgono le acque piovane e mantengono nel nome la memoria di quegli insediamenti sorti lì per favorire l’approvvigionamento idrico in un territorio dove l’acqua di superficie è pressoché assente.
.
La prima Riserva Erpetologica in Italia

In questi antichi specchi d’acqua dolce, tutti presenti all’interno di altrettante doline, depressioni originate dal carsismo, sono stati costruiti pozzi di raccolta delle acque sin dal Medioevo. Quelli oggi ancora visibili risalgono al ‘700 e come cisterne sotterranee, in cui durante l’inverno venivano convogliate e conservate le acque piovane preziose nella stagione più calda e secca, sono state utilizzate fino all’avvento dell’Acquedotto pugliese.

La maggior parte dei laghi si prosciuga completamente mentre quello di Sassano, alimentato da una condotta sotterranea che convoglia l’acqua piovana delle zone circostanti, resiste alla forte evaporazione rimanendo visibile tutto l’anno e facendo da prezioso ricovero per uccelli, pesci, anfibi e rettili.
Infatti l’habitat di questi bacini è molto particolare e non solo li rende ideali per specie in estinzione quali Bufus Smeraldinus, un rospo dalla livrea verde brillante, e Triturus Italicus, anfibio con la coda simile alla salamandra, ma li ha fatti divenire una riserva naturale regionale e anche un’oasi del WWF.


Da bambini in primavera ci recavamo ai laghetti per guardare curiosi i girini e, di settimana in settimana, assistevamo alla loro metamorfosi in rane. Ho nel tempo ampliato la mia conoscenza della fauna tipica, tra cui ci sono anche il ditisco, un coleottero dalle grandi mandibole e fenomenale nuotatore, e la biscia d’acqua. Ma solo “da grande” ho scoperto la presenza del Triops, un animale antichissimo, comparso sulla terra più di duecento milioni di anni fa. E’ un crostaceo dotato di tre occhi, da qui il nome che in greco significa appunto tre occhi, che vive in pozzanghere di acqua dolce. Quelli presenti nei nostri laghi, come le altre specie simili, sono nati ben prima dei dinosauri e a loro sono sopravvissuti.

Il loro nome scientifico è “Triops cancriformis” e non sono certo di bell’aspetto! Infatti questo crostaceo, un vero e proprio fossile vivente, si presenta con un carapace tondeggiante oppure ovale che termina in due spine, una lunga coda segmentata e tanti piccoli arti che servono a nuotare, respirare e raccogliere il cibo. La curiosità è che sono in grado di sopravvivere in ambienti molto ostili con scarso cibo e sono diffusi in tutto il mondo. Inoltre le loro uova possono schiudersi anche se sono esposte alle condizioni più avverse e dopo molto tempo la loro deposizione.
Ma come hanno fatto questi piccoli esseri a sopravvivere dal Triassico fino ai nostri giorni? Il segreto è che sono onnivori esattamente come noi umani! Difficile vederli perché in genere vivono sul fondo degli stagni, ma facendo ricerca ho trovato su internet siti in cui vendono le uova per allevare triopi in casa. Per chi vuole crearsi un piccolo Jurassic Park domestico!

Presenze che invece si sono aggiunte nel tempo sono oche e tartarughe creando numerosi danni e scompensi ai naturali equilibri del delicato habitat acquatico. Tra canne lacustri e alte piante di papiro volano libellule e farfalle e si aggirano anatre, gabbiani e perfino maestosi aironi bianchi e cinerini che usano come punto di appoggio le bocche delle antiche vasche, mentre l’acqua in superficie è increspata dal guizzo dei pesciolini rossi e dai saltelli di rospi e rane. Non sempre visibili, invece, sono i rettili che qui hanno trovato un ambiente perfetto: ben dieci tipologie, ossia circa il 50% di quelle autoctone censite nella regione, tra cui la natrice dal collare, il geco di Kotschy e il colubro leopardino.

Bello godersi questo spettacolo al tramonto quando l’acqua si tinge d’oro e rende ancora più affascinante questo prezioso ecosistema unico in Puglia, quello della Riserva naturale regionale dei Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore.
 Un’area naturale, composta da dieci doline carsiche (Lago di Triggianello, Lago di Montepaolo, Lago di Petrullo, Lago di Iavorra, Lago di Padula, Lago di Chienna, Lago di Sassano, Lago di San Vito, Lago di Agnano, Lago di Castiglione) e una profonda gravina che si estende fino alla costa di Mola di Bari.
Un’area naturale, composta da dieci doline carsiche (Lago di Triggianello, Lago di Montepaolo, Lago di Petrullo, Lago di Iavorra, Lago di Padula, Lago di Chienna, Lago di Sassano, Lago di San Vito, Lago di Agnano, Lago di Castiglione) e una profonda gravina che si estende fino alla costa di Mola di Bari.
L’importanza dell’area dal punto di vista naturalistico è nota da tempo, infatti già nel 1985 grazie a una delibera del Consiglio Comunale di Conversano è stata istituita una Riserva Erpetologica, finalizzata alla tutela dei Laghi e soprattutto di anfibi e rettili che li popolano.
Oltre a rappresentare la prima Riserva Erpetologica istituita in Italia, i Laghi di Conversano nel 1999 hanno ottenuto il riconoscimento di Area di Rilevanza Erpetologica Nazionale da parte della Societas Herpetologica Italica.

Sicuramente è un paesaggio unico ed è stato spesso pubblicizzato sulle riviste e sui siti specializzati in turismo per il suo scenario suggestivo creato da doline carsiche, boschi, oliveti, muretti a secco. E anche noi abbiamo scelto il lago di Sassano come quinta di uno dei nostri shooting fotografici, quello dedicato al foulard di Talento Fiorentino realizzato a bordo dell’Alfa Romeo Giulietta Spider di Rent Classica.

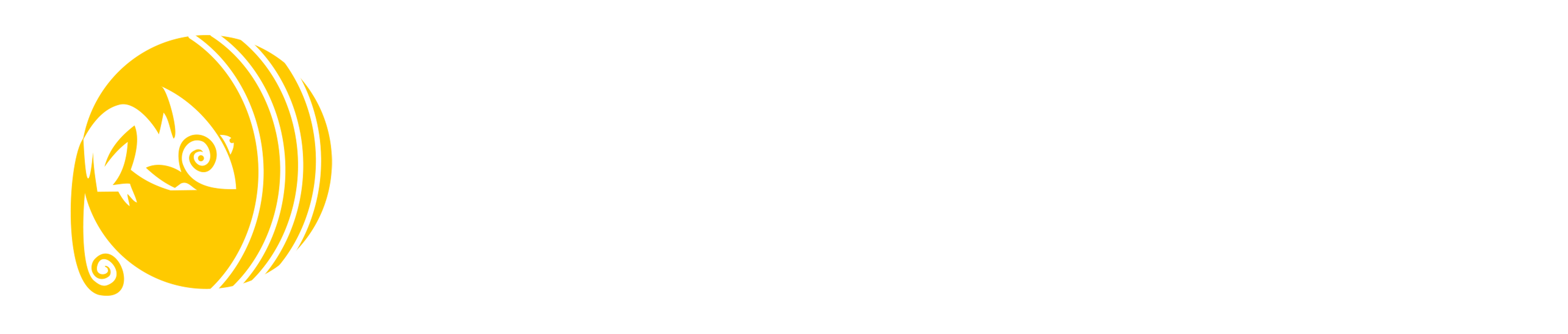











E chissà che altro ci sarà che non sappiamo ancora, certo non immaginavo mini-mandibole. A me è toccato un pezzo di natura che costeggia il quartiere dove vivo al momento (sotto Fiesole), popolato da papere parecchio attive in voli e battibecchi, un airone ogni tanto, pesci di tutte le taglie, una volta ho visto anche una biscia, insettoni e volatili, e d’estate concerto gratuito di rane che non sono riuscita ancora a scovare. Sono anche colpita dalla vegetazione, considerato che non è un parco eppure ci trovi di tutto in specie, forme e colori.
Hai citato la roccia carsica, io però credevo fosse solo in Friuli…
Avere uno specchio d’acqua vicino casa emoziona perché racchiude un continuo movimento di vita!
Riguardo la roccia carsica è una caratteristica che lega Puglia e Friuli Venezia Giulia, due regioni apparentemente lontane ma con tante affinità come ho scritto in un articolo sul nostro blog.
Questo il link dell’articolo a cui mi riferisco: https://www.cittameridiane.it/friuli-venezia-giulia-nellestremo-nord-est/
Ehi, grazie!! Anche oggi ho scoperto qualcosa!
Prego Patrizia! Qui il Cicerone lo trovi a casa sua 😉